DOMENICA 25 APRILE 2021
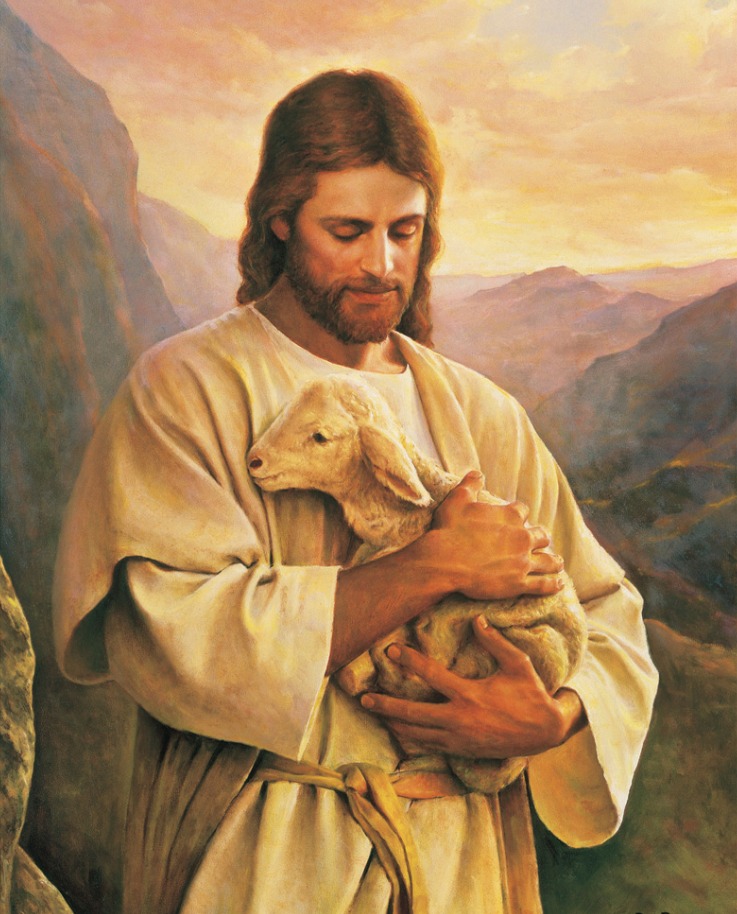
In quel tempo, Gesù disse: «Io sono il buon pastore. Il buon pastore dà la propria vita per le pecore. Il mercenario - che non è pastore e al quale le pecore non appartengono - vede venire il lupo, abbandona le pecore e fugge, e il lupo le rapisce e le disperde; perché è un mercenario e non gli importa delle pecore. Io sono il buon pastore, conosco le mie pecore e le mie pecore conoscono me, così come il Padre conosce me e io conosco il Padre, e do la mia vita per le pecore. E ho altre pecore che non provengono da questo recinto: anche quelle io devo guidare. Ascolteranno la mia voce e diventeranno un solo gregge, un solo pastore. Per questo il Padre mi ama: perché io do la mia vita, per poi riprenderla di nuovo. Nessuno me la toglie: io la do da me stesso. Ho il potere di darla e il potere di riprenderla di nuovo. Questo è il comando che ho ricevuto dal Padre mio».
(Gv 10,11-18)
Quel rapporto di profonda intimità e conoscenza, di fiducia e di accettazione, che il "buon pastore" afferma di avere con il Padre, dice di averlo anche nei confronti di ciascuna delle pecore, conosciuta una ad una, per nome. In seguito afferma anche di avere «altre pecore che non provengono da questo recinto», e che anche quelle deve guidare. Alla fine, anche queste altre pecore «ascolteranno la mia voce e diventeranno un solo gregge», con «un solo pastore». Di tutte queste pecore neppure una ne andrà perduta, perché «ascoltano la mia voce» e io «le conosco ed esse mi seguono». Nessuno e niente «le strapperà dalla mia mano», perché nessuno è più grande del Padre, «che me le ha date», e nessuno riuscirà a «strapparle dalla mano del Padre». Queste parole costituiscono un messaggio di grande fiducia e speranza per ciascuno di noi: siamo conosciuti ad uno ad uno; amati e ben-voluti nella nostra più specifica singolarità. Non ci è stato promesso che saremo magicamente esentati da tribolazioni, sofferenze, fatiche, ma solo che non saremo mai lasciati soli. Anche contro ogni apparenza. E che comunque nulla è più forte della «mano» del Padre, neppure la morte. Ma è anche un messaggio che invita ciascuno di noi ad una grande responsabilità: quello che Gesù, alla fine, dice di se stesso - «Io e il Padre siamo una cosa sola» - siamo chiamati a ripeterlo anche noi. Questa è la nostra ultima vocazione, la meta del nostro cammino verso una umanità più piena. E possiamo accogliere questo appello con fiducia e gratitudine, perché, sempre, un "buon pastore" ci guida, ci accompagna e ci assiste.
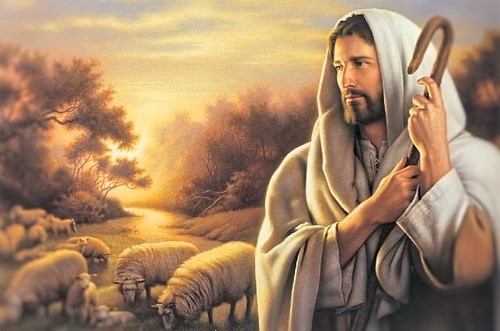
Dio onnipotente e misericordioso, guidaci al possesso della gioia eterna, perché l'umile gregge dei tuoi fedeli giunga con sicurezza accanto a te, dove lo ha preceduto il Cristo, suo pastore. Egli è Dio, e uomo, e vive e ama con te, nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen.

Il primato dell'essere sul fare e sull'avere.L'essere è uno, o può essere unificato. Il fare e l'avere invece presuppongono la molteplicità. La spiritualità monastica nella sua ricerca di semplicità difende il primato dell'essere, sebbene possa considerarlo vuoto, śūnya, e quindi non essere, asat, mu; oppure pieno, completo, plērōma, e quindi Essere supremo o assoluto. In ogni caso il primato viene dato all'essere piuttosto che al fare e all'avere [...]. Una delle parole consacrate dalla tradizione per esprimere questo secondo canone è «contemplazione». La contemplazione, malgrado l'origine della parola, equivale a theōreia, jnāna, una conoscenza che è essere. In effetti, la contemplazione è quella attività che ci colloca in uno spazio aperto dal quale possiamo osservare e contribuire al corso dell'universo; o, come dirà la Gītā, quella attività che trae diletto dal benessere di tutti gli esseri, o che mantiene la coesione nel mondo. La contemplazione pretende di essere il mezzo ultimo per raggiungere lo scopo finale della vita, vale a dire, per sostenere il cosmo o, con le parole del misticismo cristiano, per creare, redimere e glorificare (divinizzare) l'universo assieme a Dio.
(Raimon Panikkar, Beata semplicità. La sfida di scoprirsi monaco)
La contemplazione è quell'attività che «mantiene la coesione nel mondo», che costituisce «il mezzo ultimo per raggiungere lo scopo finale della vita», che è quello di «sostenere il cosmo» o, con le parole della mistica cristiana, di «creare, redimere e glorificare (divinizzare) l'universo assieme a Dio». Ma quando ci si accorge, prosegue Panikkar, che la condizione umana non può essere superata, perché non può trascendere se stessa, ecco che ciò che ha preso forma come «il mezzo ultimo» diviene esso stesso «il fine della vita, la pienezza dell'esistenza». In altre parole, la contemplazione non è più un 'mezzo' per raggiungere la pienezza della vita, ma il 'fine' di una vita vissuta nella sua pienezza. «I mezzi sono evaporati» e «si sono convertiti in fine». In questa prospettiva, il monaco come contemplativo non ha alcun «modello da imitare» o «sentiero da seguire». La vita contemplativa è 'vita' semplicemente, vita nel suo senso più pieno, esperienza mistica, si potrebbe anche dire, nel senso più profondo di esperienza integrale della vita.
Massimo Diana
