BREVIARIO UNIVERSALE
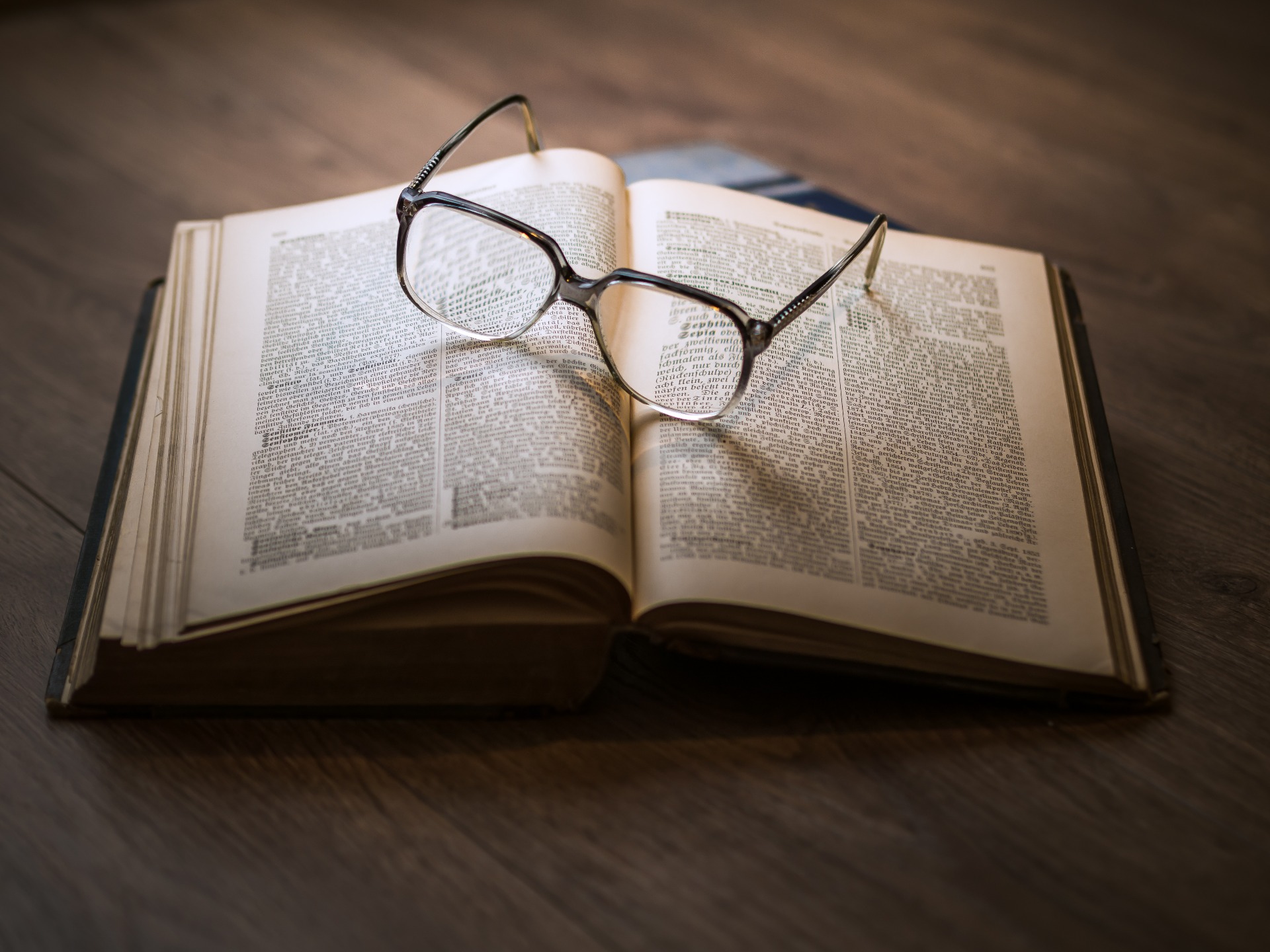
Il Breviario Universale è uno strumento per la pratica più che un libro da leggere. La vita spirituale è infatti, anzitutto, un insieme di pratiche che mirano ad agevolare e a sostenere una via individuativa, verso l'umano; pratiche che rappresentano anche una concreta via per guarire il male di vivere e curare il dolore. L'obiettivo della pratica spirituale (della meditazione come della preghiera) è aiutare a vivere con più consapevolezza - o con una maggiore presenza mentale - il quotidiano. La pratica spirituale serve a stabilizzare un modo di vivere; a consolidare la libertà rispetto agli automatismi e ai condizionamenti che impediscono di vivere nella pace, vere e proprie 'possessioni' che ci costringono ad una sofferenza sterile; a trovare un proprio centro e attorno a questo semplificare e unificare il proprio vivere. Serve a guarire lo spirito, per amare di più la vita.

Sono state due le fondamentali questioni che mi sono posto nella stesura di questo testo: «È necessario essere credenti per pregare?» e «Se si è credenti, e quindi appartenenti ad una determinata tradizione, si può o si deve pregare solo con i testi di quella religione?» La risposta è negativa in entrambi i casi: possiamo pregare anche se non siamo 'credenti', perché la preghiera - come la meditazione - è un formidabile esercizio, una pratica che, nel tempo, migliora la qualità della vita; inoltre possiamo pregare e riconoscerci, un poco, in tutte le tradizioni sapienziali e religiose, perché tutte sono capolavori della creatività umana e parlano all'uomo e dell'uomo.

Questo strumento per la pratica della preghiera costituisce una esperienza e una testimonianza di un dialogo possibile: non esiste via più sicura per i popoli e le persone per imparare ad ascoltarsi e a rispettarsi che 'pregare' insieme. Tale pratica è un modo concreto per imparare a conoscersi e a non temersi; una via tutt'altro che astratta per contribuire alla costruzione di una comunità mondiale e solidale che trascenda appartenenze religiose e nazionalismi troppo rigidi. La pratica della preghiera comune rappresenta un'esperienza e una testimonianza che contrasta l'attuale tendenza alla separazione e alle divisioni egoistiche, fondate sulla paura; la deleteria tendenza, purtroppo oggi ancora così diffusa, a erigere muri piuttosto che a costruire ponti.

Il Breviario universale non è stato pensato e costruito a tavolino ma è nato da una esperienza che riprende e sviluppa un'intuizione originale di Giovanni Vannucci. Così il monaco servita si esprimeva nell'Introduzione a Il libro della preghiera universale che diede vita ad una delle esperienze più originali e profetiche dei nostri tempi nella comunità di san Pietro alle Stinche: "La raccolta di preghiere che pubblichiamo è nata dall'esigenza di conoscere, pregando, il cuore delle tradizioni religiose cristiane e non cristiane. Non è, quindi, un'antologia di testi religiosi, ma un libro della preghiera universale. Il momento della preghiera pone la coscienza umana al di là di tutte le dispute e differenziazioni concrete, in un rapporto vivo e pacifico con il Mistero divino, fonte e origine di ogni anelito ed espressione di preghiera. Le diversità vengono annullate; le espressioni si spogliano delle loro durezze; l'anima ne esce, arricchita e dilatata, con una visione nuova dell'uomo: essere che prega non per debolezza o terrore, ma per partecipare con verità e realtà alla vita".

L'idea che sta alla base dei quattro Volumi del Breviario Universale è che un ecumenismo praticato sia possibile e alla portata di tutti: come scrive Raimon Panikkar: "È evidente che le religioni non dicono la stessa cosa e che le loro rispettive dottrine sono diverse e molte volte incompatibili. Ma è altrettanto evidente che coloro che hanno compiuto un'esperienza profonda della realtà in modo concreto, come i mistici per esempio, non percepiscono incompatibilità tra di esse". L'obiettivo non è quello di raggiungere una impossibile unificazione che finirebbe per cancellare, con violenza, ogni differenza, ma piuttosto quello di sperimentare come le meravigliose differenze della creatività umana esprimano tutte una verità; verità che non sono incompatibili tra loro, se vissute e praticate. Se dal punto di vista teorico - almeno della nostra logica occidentale - la verità non può che essere una, dal punto di vista pratico possiamo fare invece esperienza di come le verità possano essere molte, o, meglio, di come la verità sia intrinsecamente plurale.

L'esperienza che possiamo fare, praticando la preghiera universale, è di essere, insieme, un poco cristiani, buddhisti, hindù, musulmani, ebrei e anche atei. Ogni giorno, a seconda dei testi che vengono utilizzati per la preghiera e la meditazione, possiamo fare l'esperienza di appartenere, in parte, anche a quella tradizione, senza cessare di appartenere alle altre. Di appartenere, insieme, a tutte e a nessuna in particolare. Panikkar di ritorno dalla sua esperienza indiana parlava di se stesso in questo modo paradossale: "Sono partito cristiano, mi sono scoperto indù e ritorno buddhista senza aver mai cessato di essere cristiano. Anzi, al mio ritorno mi sono scoperto cristiano migliore, perché da cristiano non affermo più di essere unicamente cristiano". Una contraddizione dal punto di vista della logica ma nient'affatto dal punto di vista dell'esperienza vissuta.

L'approccio del Breviario universale allo straordinario patrimonio di testi e di esperienze spirituali dell'umanità è nel segno di quella che Besret ha chiamato spiritualità laica: "Aspiro (...) ad una spiritualità laica, per paradossale che possa sembrare l'espressione. Una spiritualità filosofica, non dogmatica, che non si riferisce ad alcuna storia particolare e non si appella a nessuna rivelazione che pretenda di imporsi come l'unica via di passaggio verso la pienezza. Una spiritualità sapienziale attenta a tutte le espressioni che la saggezza degli uomini ha potuto prendere nel corso dei millenni. Una spiritualità radicale che si sforza di attingere alla radice stessa del nostro essere. Una spiritualità che raggiunge così ciò che è alla radice delle diverse tradizioni, non in ciò che hanno di più specifico, ma al contrario in ciò che la loro specificità traduce di più universale".

È possibile entrare nel cuore di una tradizione religiosa attraverso l'esperienza della fede vissuta da chi, in quella tradizione, è cresciuto (pisteuma), e non semplicemente attraverso la conoscenza sterile e astratta delle verità dottrinali di una data religione (noema). Nella prospettiva di una spiritualità laica le religioni sono un insieme di meravigliose narrazioni archetipiche, un prodotto umano, della psiche inconscia, per dare forma al Mistero della Vita e ai conflitti che perlopiù tutti attraversiamo nel nostro divenire quel che siamo. Un prodotto cioè di quella parte della psiche che, filogeneticamente, è stata predominante per oltre il 97% della nostra storia umana e la cui importanza è fondamentale anche, ontogeneticamente, nella nostra storia di singoli individui nei primissimi anni di vita. Il mondo di questa parte arcaica della psiche è numinoso, pieno di angeli e demoni, dei ed eroi ed è di questo che parlano queste meravigliose narrazioni.

L'esperienza spirituale è fondamentalmente questione di pratica. Le "questioni metafisiche" possono ossessionare e distogliere dall'unica cosa che veramente conta: come divenire ed essere (più) umani. Il rischio della vita spirituale è quello di restare intrappolati nella rete di questioni irrisolvibili sul piano della pura ragione; sarebbe come impiegare tutto il tempo della vita (che non è infinito) per costruire la zattera, ma senza mai metterla in acqua per attraversare il fiume. Nella tradizione buddhista si dice che al Buddha furono spesso poste questioni metafisiche ma che egli soleva rispondere con l'immagine della freccia avvelenata che ci colpisce: non abbiamo il tempo (e non conviene farlo) di porci troppe domande: chi ha scagliato la freccia, perché l'ha fatto, quale veleno ha utilizzato... prima di riuscire a trovare una risposta saremmo già morti. Ciò che serve è, senza esitazione, afferrare la freccia e strapparla, prima che sia troppo tardi. Ortoprassi. Nella tradizione ebraica solo quando i Leviti che portavano l'Arca dell'Alleanza scesero nelle acque del Giordano, queste si aprirono: bisogna scendere in acqua, mettersi in cammino... senza aspettare prima una risposta e una certezza, altrimenti si rischia di rimanere eternamente ad aspettare un segno che non arriverà mai.

Le pratiche spirituali laiche hanno un grande obiettivo: quello di aiutarci a divenire (più) umani; non una 'ascesa' (al divino) ma una 'discesa' (nell'umano); si ascende discendendo. Il cammino spirituale è infatti null'altro che la via a quell'umano che tutti ci accomuna ma che ancora non siamo in pienezza. Non siamo, infatti, ancora l'Uomo nella sua pienezza. L'etologo Konrad Lorenz di fronte alla vexata questio teologica del missing link, dell'anello di congiunzione tra la scimmia e l'uomo, rispondeva con una interessante battuta: "L'anello di congiunzione tra la scimmia e l'Uomo, siamo noi!". Noi non siamo ancora pienamente umani: il Cristo e il Buddha potrebbero essere due icone, nelle rispettive tradizioni, di cosa voglia dire diventare ed essere pienamente umani. Il cammino spirituale, inteso laicamente, è la via per poterlo diventare anche noi.

Non esiste più una Via universale, da imitare pedissequamente. Le grandi narrazioni collettive di senso sono entrate in crisi, non rispondono più alla domanda profonda di tanti uomini e donne del terzo millennio. La sfida del nostro tempo è che ciascuno deve trovarsi la propria via. Ciascuno ha la sua via: "Credetemi. Quella che vi do, non è né una dottrina né un insegnamento. E da quale pulpito potrei indottrinarvi? Vi informo della via presa da quest'uomo, della sua via, ma non della vostra. La mia via non è la vostra via, dunque non posso insegnarvi nulla. La via è in noi, ma non in dei, né in dottrine, né in leggi. In noi è la via, la verità e la vita (...). Guai a coloro che vivono seguendo dei modelli! La vita non è con loro. Se voi vivete seguendo un modello, allora vivrete la vita del modello, ma chi dovrebbe vivere la vostra vita, se non voi stessi? (...). Gli indicatori di via sono caduti, davanti a voi si aprono incerti percorsi (...). Esiste solo una via ed è la vostra via". Ciò che il Cristo disse di se stesso: "Io sono la via, la verità, la vita"; "Io e il Padre siamo una cosa sola" siamo ora tutti interpellati e provocati a dirlo anche di noi stessi - dice Jung. Questo il senso dell'essere dei Cristi o dei Buddha: un Cristo o un Buddha (non il/quel Cristo o Buddha, imitandolo), cioè vivere la nostra vita con la stessa verità e intensità con le quali Cristo e Buddha vissero la loro.

La scelta e l'organizzazione dei testi del Breviario Universale è stata guidata
dalla sensibilità occidentale e cattolica a cui appartengo e in cui mi
riconosco: la prospettiva cristiana
rimane dunque l'orizzonte di riferimento. I testi sono stati distribuiti
secondo un ciclo annuale, a partire
dal mese di dicembre, con il tempo di Avvento,
che apre, nella tradizione cristiana, il nuovo anno liturgico. La settimana è
così organizzata: Domenica e Lunedì testi della tradizione cristiana; Martedì
testi della tradizione gnostica, taoista e zen; Mercoledì testi della
tradizione induista; Giovedì testi della tradizione buddhista; Venerdì testi
della tradizione islamica; Sabato testi della tradizione ebraica.

Per ogni giorno vengono offerti due momenti di preghiera: uno per il mattino e uno per la sera, secondo questa struttura di base: una Introduzione (al mattino con Inni propri del tempo liturgico per la Domenica e il Lunedì; con una introduzione specifica per tutti gli altri giorni. Alla sera, invece, l'introduzione è sempre costituita da un Inno proprio del tempo); tre testi di preghiera, appartenenti alle varie tradizioni; una lettura lunga, tratta da testi appartenenti alle varie tradizioni (la Domenica e il Lunedì i testi del mattino sono quelli proposti dalla liturgia cristiana, secondo i cicli A,B,C per la Domenica e gli anni pari e dispari per i giorni feriali); il commento spirituale, con l'obiettivo di aiutare l'ascolto profondo, la comprensione, e indicare alcune vie possibili per incarnare nella vita di tutti i giorni quanto letto; il momento del silenzio e dell'ascolto profondo, che può essere più o meno lungo a seconda delle possibilità e della disponibilità di ciascuno; la preghiera di lode e di intercessione universale; il Padrenostro; una preghiera conclusiva.

Ogni Volume del Breviario Universale ospita due Appendici: la prima per la celebrazione delle principali feste del calendario interreligioso: dal Bodhi Day a Chanukkah; dalla Giornata mondiale delle religioni all'Anniversario della morte di Gandhi; dal Sarasvati Puja al Maha Shivaratri; da Purim a Holi; dal Magha Puja al Lailat al Miraj; da Pesak al Ramadan; dal Vesak a Shavuot; dal Lailat al Kadr all'Asala Puja; dal Tish a Be'hav a Krishna Janmastami; da Navaratri allo Yom Kippur; da Sukkot al Mawlid an Nabi; dal Zhong-Qiu al Giorno del ringraziamento. La seconda contenente 48 schede complessive sui grandi personaggi dello spirito, che vanno a costituire una sorta di santorale laico e interreligioso.
Massimo Diana
Pagina Facebook del Breviario Universale:
https://www.facebook.com/BreviarioUniversale/?modal=admin_todo_tour
